È stato detto che “le motivazioni per l’uomo sono il carburante della vita”. Quando si è motivati, si compiono cose apparentemente impossibili: nello sport, nel dedicarsi ad aiutare il prossimo, nella dedizione alla famiglia, nell’amore verso il proprio partner e in tante altre situazioni che spingono una persona a impegnarsi per una vita e crederci, facendo anche grandi sacrifici.
Peppino Manzi è nato in una famiglia che, già nei primi decenni del ‘900, praticava questo mestiere dell’accoglienza alberghiera, sia da parte di sua madre che di suo babbo, scomparso a causa di una lunga malattia quando era ancora molto piccolo. Tuttavia, ha ricevuto da sua madre tanti racconti legati al suo amato lavoro praticato anche in giro per il mondo, che lo hanno fatto sognare già a nove anni che questa sarebbe stata la sua carriera professionale e il senso da dare alla sua futura vita.
Nella sua passione per portare avanti quest’impegno, è stato motivato perché fin da piccolo ha desiderato e voluto abbracciare quel mestiere che il suo babbo svolgeva con piacere e in maniera molto professionale. Come figlio, non ha avuto la possibilità di vivere insieme a lui abbastanza anni per ricevere direttamente i suoi insegnamenti di vita, ma crescendo ha raccolto i racconti della mamma; sostava davanti all’armadio dove erano riposti i suoi indumenti di servizio: giacche bianche, la marsina, il frak e intanto sognava.
Poi, lavorando nei locali precedentemente occupati dal babbo,

viveva nel ricordo degli aneddoti raccontati dai datori di lavoro e dai vecchi colleghi, che parlavano delle sue capacità come “cameriere” prima di tutto, la naturale simpatia che conquistava la clientela e il farsi voler bene da chi lavorava accanto a lui; la buona presenza comportamentale e nell’abbigliamento, che trasmetteva eleganza nel mestiere; e la capacità tecnica che applicava nella sua professione. Peppino voleva imitarlo per ricordarlo sempre, perché gli mancava tanto.
I racconti di sua madre non si limitavano solo alle esperienze del babbo, ma gli narrava anche dell’attenzione, fatta quasi con sublime adorazione, che suo nonno materno, che non ha conosciuto, alimentarista con negozio in piazza Garibaldi a Cervia, s’impegnava con meticolosità per sistemare la merce del suo negozio: le pile di mele ben ripassate con un panno per lucidarle e impilarle a piramide. Probabilmente questa attenzione ai piccoli particolari dedicata alla merce ha contribuito a trasmetterla anche a Peppino, per eredità, il piacere di essere meticoloso e preciso nelle funzioni del suo lavoro.
Poi, di fianco al negozio del nonno, sotto i portici della piazza, c’era il bellissimo bar dello zio.
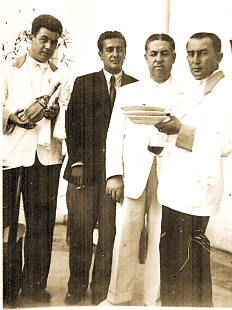
Allora si chiamava “Caffè Walter” (ora è il “Bar Roma”), arredato con tende e velluti, poltrone e divani e luci soffuse: tutte le bellezze degli arredi cittadini, ancora non viste nella piccola e provinciale cittadina di Cervia. Lo zio, ambizioso riguardo al suo locale, andava a scoprire queste novità nelle più grandi città per poi portarle nel suo “caffè alla moda” e offrirle alla sua clientela di concittadini e ai pochi turisti della breve stagione estiva di quei tempi.
Il destino e la nascita del Maestro sono sempre stati legati al “bar e alla ristorazione”. È stato il bar dello zio che ha portato ad assumere il cameriere Manzi, proveniente da Ravenna con già notevoli esperienze di mestiere, che poi divenne suo padre.
Crescere non è mai facile, ma ci sono esperienze che lasciano cicatrici profonde, insegnando lezioni che si portano avanti per tutta la vita. L’infanzia di Peppino è stata segnata da episodi che non solo hanno turbato la sua crescita morale, ma hanno anche accelerato quel desiderio di diventare adulto, di superare le difficoltà e di trovare un senso in mezzo alle avversità.
Dalle persone ebbe la prima incisiva delusione quando aveva solo 11 anni e frequentava l’ultimo anno delle scuole elementari. L’episodio lo ferì enormemente, tanto da ricordarlo ancora oggi, e segnò intensamente il suo animo perché subii questa enorme cattiveria, così la considerai data la sua giovane e inesperta età, dalla sua, fino ad allora amata, maestra delle elementari.

Maestra che considerava molto capace e umana, oltre ai suoi incisivi e severi insegnamenti scolastici: era dolce quando, mezz’ora prima della campanella, ci leggeva qualche romanzo di tenore sociale. Ricorderà sempre le letture fatte in modo tale che gli alunni eravamo assorbiti dalle vicende dei protagonisti e dal modo in cui la Maestra esprimeva con passione; essendo, fra l’altro lei gli anni ‘50, molto impegnata politicamente.
Nel mese di marzo di quell’anno suo Babbo morì, dopo quattro anni di sofferenze per una malattia, allora definita “incurabile”, lasciandoci affranti dal dolore e senza alcun reddito per campare.
Ritornò a scuola con quel peso e quella disperazione nel cuore, abbattuto dagli eventi e nel periodo pre-pasquale con i suoi coetanei erano impegnati a raccogliere i soldi per fare un regalo alla Maestra. Lui non avevo alcuna possibilità concreta di partecipare a questa colletta e, con me, qualche altro alunno che, per impossibilità o perché la loro famiglia la pensava diversamente, non partecipò.
E così, prima delle vacanze pasquali, le fu offerto il regalo accompagnato dai nominativi dei partecipanti. Ritornato a scuola dopo il periodo di vacanze, la maestra li sorprese annunciando l’intenzione di portarli in passeggiata a Milano Marittima con meta al campo sportivo in mezzo alla pineta.
Fu una giornata gioiosa, benché Peppino non partecipasse molto al gioco del pallone, rimanendo con i suoi mesti pensieri sui gradini della tribuna a contemplare l’allegria dei miei compagni. A un certo orario, la Maestra fece fare una pausa ai giochi e, da due immense sporte che si trascinava dietro durante il tragitto, tirò fuori dei favolosi e invitanti panini che distribuì chiamando ad alta voce i compagni di studi da una lista che teneva nelle sue mani.
Conclusione: il Maestro e altri due o tre coetanei non facevamo parte di quella lista in quanto era la stessa che partecipò alla colletta; di conseguenza, rimasero mortificati a guardare i compagni che ridevano e mangiavano in allegria. La maestra aveva sentenziato che alcuni non meritavamo il premio tanto ambito a quei tempi di grande magra.
La maestra conosceva bene la situazione familiare di Peppino e pertanto lei, ben sapendo che non era stata una irriconoscente volontà verso la sua persona, rimase tanto male con un grosso groppo alla gola che gli riempiva di cattiva considerazione delle persone e così cominciò a prepararsi nella vita a queste eventualità negative.
Contrariamente a ciò che poi constatò nel prosieguo della sua vita, non usò mai lo stesso metodo di comportamento, ma l’episodio gli suggerì che doveva evitare di comportarsi in maniera così meschina con le persone che lungo la vita avrebbe incontrato.
Riflessioni su un’infanzia rubata: crescere tra lavoro e bullismo
Peppino iniziò a lavorare a soli nove anni. Era una cosa comune a quei tempi per i ragazzi ancora minorenni: si diceva che il lavoro in bottega servisse per “toglierli dalla strada e insegnargli un mestiere”. Così, le sue giornate erano divise tra scuola al mattino e bottega al pomeriggio. Non era un lavoro scelto, ma imposto dalle circostanze. Dopo la morte di suo padre, le responsabilità aumentarono e con esse anche il peso delle difficoltà.
Al sabato e alla domenica, invece di riposarsi o giocare come gli altri bambini, andava con sua madre a lavorare al bar del “Dancing Giardino d’Inverno”. Era una sala da ballo che chiudeva a notte inoltrata. Lavorare lì, almeno, aveva un lato positivo: il locale era lo stesso dove suo padre aveva lavorato come cameriere, e sia i colleghi che la clientela erano gentili con loro. In qualche modo, quel posto rappresentava un legame con lui, un ricordo che gli dava conforto.
Ma il vero inferno lo viveva durante la settimana, nel lavoro di elettricista. Fino ai quattordici anni, quel mestiere lo ha esposto a un tipo di bullismo che non proveniva dai coetanei, bensì da ragazzi più grandi. Avrebbero dovuto essere più maturi, più responsabili, ma invece si divertivano a tormentarlo con scherzi crudeli e pericolosi. Ricorda uno di questi che si fingeva di essere Frankenstein e gli stringeva il collo, mentre un altro gli infilava la corrente da 220 volt nella testa. Non erano solo scherzi: erano veri e propri abusi che lo lasciavano spaventato e umiliato.
Le giornate finivano sempre tardi, e quando finalmente poteva tornare a casa, spesso trovava la sua bicicletta agganciata al sostegno portabandiera sotto la finestra del secondo piano del palazzo. Doveva recuperarla con fatica dopo una lunga giornata di lavoro. E non era finita lì: un episodio particolarmente crudele accadde mentre lavorava all’ospedale civile di Cervia. Finito il lavoro era già sera inoltrata, Peppino scese per recarmi velocemente a bottega seguendo gli operai. Il manubrio della bici era pieno di rotoli di filo elettrico, e aveva una scala sulle spalle. Una volta in sella e spinto sui pedali, si accorse che qualcuno aveva infilato pezzi di fil di ferro nella catena della bici, facendola inceppare.
Tolse il filo con rabbia repressa e continuò a infilare il vialetto che portava verso l’uscita vicino alla stazione ferroviaria, dove c’era un grosso cancello in ferro con due ante. Quegli “uomini” avevano messo un fil di ferro tra le cancellate in modo che, arrivando in velocità nel buio, lo inforcasse. Le cancellate gli si chiusero in faccia, lasciandolo stordito e frustrato. Ogni giorno c’era qualcosa di nuovo per rendere la sua vita più difficile.
Un altro episodio che lasciò una traccia indelebile, non solo nella ferita mal cucita al braccio destro, ma anche nella mente. Aveva circa 12/13 anni quando lavorava ancora alla bottega degli elettricisti. Arrivati alla primavera, con l’avvicinarsi della stagione estiva di quegli anni ’50, si acceleravano i lavori per completare ville e alberghi. C’era un gran da fare per terminare i lavori nelle varie ville e alberghetti che fiorivano costantemente a Milano Marittima, dove il fervore edilizio stava trasformando la località in una meta turistica emergente. La primavera era un periodo particolarmente intenso: via i muratori che avevano costruito, dentro gli elettricisti per completare i lavori per l’elettricità, infilando i fili nei tubi degli impianti.
In un’occasione del genere, alle 21 di sera in una villa dove stavamo svolgendo dei lavori con un operaio serio, un uomo che non gli aveva mai fatto del bullismo, ma con il quale ebbe più di una disgrazia: una prima volta in un alberghetto di prossima apertura ebbe la sventura di bruciarsi gravemente a un piede e a una mano, proprio come accadde recentemente al noto cantante Gianni Morandi.
Questa volta, nella villetta, a tarda ora serale, i due stavamo infilando i fili elettrici, uno in una stanza e l’altro in un’altra stanza; avendo a disposizione una sola scala, posizionata in un luogo piccolo e stretto, l’operaio spostò la scala per utilizzarla altrove, lasciando il Maestro in una posizione precaria. Nel tentativo di continuare il lavoro senza l’ausilio della scala, perse l’equilibrio e cadde da un’altezza considerevole, riportando una frattura al braccio destro.
Fu portato d’urgenza all’ospedale, dove iniziò un percorso medico complesso. Dopo diversi tentativi falliti di ridurre la frattura con metodi tradizionali, il chirurgo Scaravelli decise di intervenire chirurgicamente. Nonostante non fosse un ortopedico, il medico affrontò l’operazione con determinazione, assieme alla sua assistente infermiera Ida e a suor Venanzia, che lo consolava con delicate carezze durante l’intervento. Tuttavia, le risorse mediche dell’epoca erano limitate, e l’anestesia utilizzata lo lasciava capire e sentire tutto ciò che si faceva al suo braccio e non riuscì ad isolarsi completamente dal dolore e dalla consapevolezza dell’intervento. Sopportò l’intera procedura con coraggio, lasciandosi alle spalle non solo una cicatrice fisica, ma anche un ricordo indelebile.
Il periodo di convalescenza durò 40 giorni, durante i quali fu costretto a rimanere a casa con il braccio ingessato. Tuttavia, le difficoltà non si limitarono all’aspetto fisico. All’epoca, i lavoratori spesso operavano in nero, privi di qualsivoglia protezione assicurativa o previdenziale. Di conseguenza, il “padrone” della ditta decise di sospendere il pagamento del magro stipendio settimanale di 1.000 lire, aggravando ulteriormente la situazione economica della sua famiglia.
L’atteggiamento del datore di lavoro appariva tanto più ipocrita alla luce della sua appartenenza dichiarata a un partito politico che professava solidarietà verso gli operai. A quei tempi Peppino e la sua mamma avevamo paura di reclamare i loro diritti, temendo che li etichettassero come lamentoni contestatori e poi non ci dessero più lavoro in paese.
Fu solo grazie all’intervento deciso di un conoscente della famiglia che il datore di lavoro comprese la gravità della situazione e riprese a versare regolarmente lo stipendio. Questo episodio non è solo il racconto di un incidente sul lavoro, ma anche una testimonianza delle condizioni precarie in cui molti lavoratori operavano negli anni del dopoguerra. Oggi, guardando indietro a quegli anni difficili, è impossibile non riflettere sul lungo cammino percorso dalla società italiana in termini di sicurezza sul lavoro e tutela dei diritti degli operai. Tuttavia, è altrettanto importante ricordare storie come questa, che ci insegnano quanto sia prezioso ciò che è stato conquistato e quanto sia necessario continuare a vigilare affinché nessuno debba mai più affrontare simili difficoltà.
Potremmo continuare con tanti altri episodi simili, ma ogni ricordo porta con sé una grande tristezza. Nonostante tutto, queste esperienze gli hanno insegnato molto. Lo hanno fatto maturare in fretta e gli hanno dato una consapevolezza profonda. Ha imparato l’importanza del rispetto, della gentilezza e della comprensione.
È stato davvero difficile affrontare tutte quelle sfide già da bambino. Lavorare così presto, subire bullismo e dover crescere in fretta non è certo facile per nessuno. Però, ha trovato una forza incredibile dentro di se stesso. È bello vedere come queste esperienze, per quanto dure, gli abbiano insegnato ad essere una persona più consapevole e rispettosa verso gli altri. Non tutti riescono a trasformare il dolore in una lezione di maturità di vita così importante.
Oggi il Maestro guarda indietro a quegli anni con un misto di amarezza e gratitudine. Amarezza per ciò che ha subito, ma gratitudine per ciò che gli ha insegnato. La vita non è stata facile, ma gli ha dato una forza interiore che porto con se ogni giorno. E forse è proprio questo il senso delle difficoltà: trasformarle in lezioni che ci rendono persone migliori.



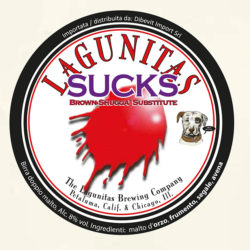



Devi effettuare l'accesso per postare un commento.